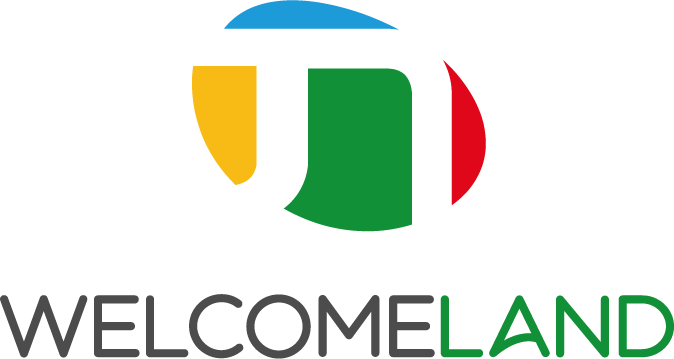Quando la primavera dimostrava stanchezza, al ragazzo scontroso capitava, la mattina dopo la scuola e in attesa del pranzo che raramente iniziava prima delle quattordici e trenta, di finire sempre nello stesso campo sotto alle finestre di casa.
Spesso era da solo, ma aveva la gran fortuna di poter scorrazzare in quell’ampio spazio situato sul fianco del versante nord-ovest della montagna su cui si staglia, a oltre mille metri, la città di Troina.
Era chiamato u Chianu ‘a Fera, il Piano della Fiera, poiché servito per molto tempo all’allestimento di grandiosi mercati del bestiame.
Però tanto piano non è mai stato. Brullo, solo chiazze di erbe medicinali e da pascolo, indurito dallo scontro con la tramontana proveniente dai Nebrodi e al tempo stesso frantumato dalle piogge, il terreno argilloso del versante era una enorme frana pentita. In basso, il fiume era il suo confine.
Sul versante opposto, invece, le pendici dichiaravano di essere possedute da migliaia di sussurranti spiriti frondosi, nemici del fuoco.
Verso nord, nel lato dove si tenevano le fiere, il chianu accarezzava un magnifico chiostro basiliano, l’altro lato confinava solo con delle misere case con l’uscio aperto su giacigli di paglia destinati anche agli indispensabili animali da lavoro. Degradava a sud-ovest per poi cambiare nome in ‘u Chianu ‘i Fuossi, Piano dei Fossi: una zona di frana ancora più ampia, fatta di avvallamenti divisi da lame di roccia, invasi e minuscoli canyon, rughe della terra.
Guardando a sud, il ragazzo poteva notare che i rilievi dei colli e delle relative valli erano scolpiti sino al mare come una specie di lungo e tortuoso tunnel; sapeva che da lì arrivavano, preceduti dall’umido, stormi di uccelli migratori, insieme a una folta colonia di rondini che di solito si fermavano a lungo. In seguito, con l’arrivo del caldo vento secco del deserto africano, nell’aria sciamavano persino nubi di cavallette e locuste e tanta, tantissima sabbia dorata.
Nella tarda primavera, sul chiano persistevano alcuni smottamenti a gradoni che davano origine ad altrettanti piccoli stagni che, con grande gioia del ragazzo, ospitavano diversi tipi di anfibi e con grande disappunto della madre inghiottivano spesso gli abiti buoni della scuola in orridi fanghi assassini.
Quella era la sua palestra, scenario per epiche imprese di fantasia, per sogni a occhi aperti, come quella volta che i cugini lo avevano portato a consegnare del cibo allo zio Turi, decisamente impegnato nella fiera di quell’anno. Tra tende e bivacchi, mischiati tra centinaia di armenti tenuti da uomini rigorosamente vestiti di panno, aveva visto, o aveva creduto di vedere, anche alcuni personaggi in lunghe vesti chiare e strane cavalcature gibbose.
Quel giorno del 1963 era caldo e lui era di nuovo al chiano, il terreno quasi asciutto iniziava la rapida trasformazione estiva in manto di stoppie e cardi selvatici molto spinosi – i pisciacani, il cui cuore sfilettato dall’immancabile coltellino stilla un succo ottimo per dissetarsi quando arriva lo Scirocco. I cardi devono questo nome al fatto di essere, spesso, l’unica forma di vegetazione con ambizione all’ascesa verticale e quindi in grado di scuotere l’istinto dei randagi; in tempi più grami le ruvide foglie venivano fatte seccare dai più grandi per sostituire l’introvabile ma necessario tabacco, e si diceva che dessero anche un senso di euforia maggiore rispetto alla pianta esotica.